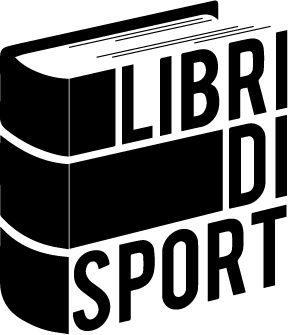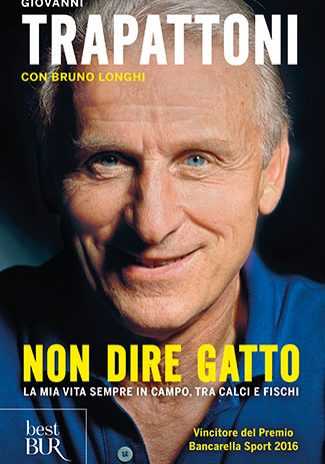Intervista a Giuseppe Pastore

Chiacchierata con l’autore de La squadra che sogna
Giuseppe Pastore è un giornalista de La Gazzetta dello Sport, collabora con L’Ultimo Uomo, Wired ed Esquire, in passato ha collaborato con Sky Sport. Scrive prevalentemente di calcio, ma con 66thand2nd ha pubblicato il libro La squadra che sogna, che racconta la nazionale italiana di pallavolo di Julio Velasco, su cui verte la nostra intervista.
Da dove nasce l’idea di un libro del genere?
«L’idea nasce in parte da una storia scritta da me sotto forma di long form per L’Ultimo Uomo nell’estate 2019; quella era l’estate in cui l’Italia maschile di volley si stava per qualificare per le Olimpiadi di Tokyo. Io mi trovavo a Bari ed ero andato a vedere la partita decisiva contro la Serbia e avevo pensato alla storia dell’Italia di Velasco perché si respirava il clima olimpico. L’articolo è stato poi letto dai responsabili di 66thand2nd che mi hanno proposto di farlo diventare un libro».
Che tipo di lavoro hai dovuto svolgere per scrivere il libro?
«Non è stato semplice reperire le partite per intero, sono riuscito a trovarle complete solo perché pubblicate da account russi o giapponesi. Questo è sì curioso ma rende anche l’idea di quanto quella squadra fosse stata apprezzata in tutto il mondo. Rivedere integralmente i match è stato il punto di partenza, ho poi intervistato Claudio Palmigiano, il telecronista di Tele Montecarlo che aveva seguito l’Italia in giro per il mondo fino a Barcellona ‘92. In seguito ho dovuto fare una ricerca d’archivio che è andata oltre la pallavolo, perché ho pensato che sarebbe stato più giusto contestualizzare dal lato politico, sociale e sportivo la vicenda trattata. La ricerca a 360° ha riguardato tutti i lati della società che in quegli anni in Italia era soggetta a cambiamenti molto forti, con il crollo della Prima Repubblica e delle crisi economiche che ebbero anche ripercussioni sulla pallavolo italiana. La pallavolo ha un boom di 2/3 anni a seguito del quale si assiste però ad un crollo altrettanto verticale, avvenuto in coincidenza con le implicazioni di Gardini in Tangentopoli e con il disimpegno di Berlusconi. In questo clima l’Italia del volley resta stabilmente ai vertici grazie a Velasco e ai giocatori e naviga da sola in un periodo dove la Federazione è spesso commissariata, non vengono pagati i premi e cambiano tanti presidenti».
In un libro che parla di tantissime gioie e dolorosissime sconfitte: qual è stata la cosa più difficile da raccontare?
«Per come la vedo io è più facile raccontare una sconfitta di una vittoria; offre quasi più gusto in quanto il lato drammatico di una storia dev’esserci sempre. È stato più facile raccontare il lato oscuro di una squadra perfetta che, per motivi apparentemente inspiegabili, però perde. E perde là dove ferisce più nel profondo: le due partite olimpiche, quelle partite che quella squadra teneva a vincere più di ogni altra cosa. C’è quindi un cortocircuito tra l’aver vinto tutto il resto e non aver vinto lì dove si “doveva” vincere. Questa è una cosa che ho sempre trovata affascinante perché, visto il riconoscimento della Federazione Internazionale di squadra più forte di tutti i tempi, ci si aspetterebbe che abbia vinto un’Olimpiade. Le vittorie sono state talmente tante da sembrare quasi ruotine e formalità anche per gli stessi giocatori. Per fare un esempio nel 1994, quando l’Italia vince i Mondiali, il pensiero è già ad Atlanta sia per giocatori, per l’allenatore e anche per i giornalisti che non celebrano quel trofeo come dovrebbero. Ciò è la condanna dei perfezionisti che pensano sempre a migliorarsi: vale per Jordan, per Federer e per Ronaldo. Chi vince sempre non si accontenta mai. Ciò porta la Nazionale di Velasco ad arrivare ad Atlanta con una pressione notevole che poi sarà l’origine della nostra sconfitta».
Atlanta ‘96 e Barcellona ‘92 nel giudizio su questa squadra come vanno letti? Offrono più epica alla narrazione o saranno ricordati per sempre come la mancata quadratura del cerchio?
«Fa parte dell’1% di imprevedibilità che c’è nello sport, anche in uno sport come la pallavolo dove quasi sempre vince il più forte. Questo aumenta in maniera paradossale l’epicità di quella squadra, talmente gigantesca le cui cadute sono altrettanto gigantesche. Con l’Olanda a Barcellona si arriva ad una situazione dove l’ultimo punto è match point per entrambe le squadre. Ad Atlanta abbiamo avuto comunque il match point. Vincere e ripetersi ad altissimi livelli sempre è impossibile: Velasco ci è riuscito per 8 anni, trattando la nazionale come un club e giocando 40 partite all’anno. In questa storia è eccezionale tutto anche il contesto economico di quegli anni in cui la pallavolo esplode a livello mondiale. Tutto ciò è amplificato da quelle due sconfitte. Proprio come il mito di Niki Lauda è amplificato dal rifiuto al Fuji di correre nel 1976 o quello di Villeneuve dal non aver vinto mai un Mondiale, il mito di Federer è anche segnato dai due match point falliti sul servizio contro Djokovic a Wimbledon nel 2019. Probabilmente fa parte di un mito soprattutto all’europea, mentre lo sportivo americano “alla Jordan” vuole solo vincere e il copione americano prevede per forza il lieto fine. Il copione all’europea rende questa storia ancora più affascinante. Inizialmente avevo pensato di cambiare il finale a mo’ di Tarantino, ma poi ho ripiegato pensando che occorresse far parlare i fatti e la storia. Non si può avere sempre ciò che si vuole, come cantavano i Rolling Stones, e probabilmente è stato giusto così».
Se tu dovessi sintetizzare il valore di Velasco sia per la quella squadra che per la pallavolo italiana e Mondiale, cosa diresti?
«Velasco è stato come un esploratore. Verrebbe da dire che l’America era già lì, qualcuno doveva però scoprirla! I giocatori erano già formati (alcuni erano stati a Seul nel 1988 come Zorzi, Giani e Lucchetta), i soldi nel mondo della pallavolo c’erano e ci sarebbero stati per almeno 3/4 anni: c’era tutto, serviva uno che mettesse tutto assieme e facesse scattare quell’interruttore mentale. Velasco riesce a entrare nella testa dei giocatori e trova la chiave. Il mister argentino è il click mentale di quella squadra. Velasco è una specie di genio che riesce con l’intelligenza relazionale: entra in sintonia non solo con una persona, ma con circa 10/15 persone diverse tutte con caratteri e personalità fortissime. Non va per forza d’accordo con tutti, a volte è necessario litigare e farsi vedere come un cattivo, come un rompiscatole per coalizzare un gruppo contro di sé e farlo rendere ancora di più. Velasco riesce in 8 anni a cambiare registro ogni volta: prima è padre, poi maestro, psicologo, manager, diventa anche una specie di capo lager tedesco. È un’illusionista del pensiero che entra nella mente. Velasco è in grado di usare degli esempi efficaci e bellissimi, riesce subito a far capire le cose con una chiarezza elementare. In questo modo Velasco fa in modo che tutti i giocatori pensino quello che lui vuole che debbano pensare: è una sorta di manipolatore delle menti».
Dei personaggi raccontati chi è quello che ti ha affascinato di più? E invece chi secondo te ha goduto di meno mediaticità di quanto meritasse?
«La grandezza di Bernardi è tale che lui diventa il giocatore più forte del mondo, assieme a Kiraly, senza essere stato un personaggio mediatico. È talmente superiore da un punto di vista tecnico che riesce ad imporsi senza nemmeno essere personaggio. Lo paragonerei a Paolo Maldini. Invece il personaggio più interessante è Andrea Lucchetta, capitano della prima Italia del 1990, leader naturale per carisma e indole. Ingiustamente passa alla storia come il clown di quella squadra che subisce il fascino della ribalta, personaggio guascone molto divertente e grande comunicatore. Ma in realtà Lucchetta si porta dietro una grande profondità e dei punti oscuri, come il senso di morire che descrive di aver provato sul podio dei mondiali in Brasile. Lucchetta contiene delle profondità che sono probabilmente quelle che lo hanno portato ad essere il capitano di una squadra ricca di personalità molto forti che sono riuscite a coalizzarsi. Essere il capitano di quella squadra voleva dire avere un’intelligenza e una sensibilità non comuni».
La partita con la P maiuscola che esemplifica di più quella Nazionale qual è stata?
«Il 3-1 contro l’Olanda nella finale dei Mondiali del 1994. Anzitutto rappresenta un aspetto difficilissimo per lo sport che è quello di riconfermarsi e inoltre costituisce anche il punto più alto a livello mediatico per quella nazionale in quanto quella partita fu vista da 4 milioni e mezzo di telespettatori. In quella partita demoliamo l’Olanda. Nel corso di quel mondiale non andiamo mai al tie break e vinciamo il 4° set di quella finale con il punteggio di 15-1. Il 4° set è davvero un massacro da cui emerge il sottile sadismo di alcuni nostri giocatori nell’infierire sull’avversario. Quella che si vede in quel frangente è la cattiveria che trovi nei fuoriclasse come Jordan, Djokovic, la Mamba mentality. Quella mentalià era già in possesso di quei giocatori, a prescindere da Velasco. Per me quella resta la massima espressione di potenza e di grandezza».
Dopo aver rivisto le partite e ripercorso i fatti qual è la sensazione che hai provato davanti alla Nazionale di Velasco?
«Il fatto che fosse stata davvero una squadra complicata da gestire. Se uno si limita a scorrere gli almanacchi non ci fa caso, in quanto spesso non ci si rende conto della difficoltà che c’è nella vittoria. Oggi rischia di essere un riflesso incondizionato il vincere dopo aver vinto. Invece c’è tutto un senso di appagamento e stanchezza mentale in quella pallavolo dove non sapevi quanto potessero durare le partite. Oggi si arriva a 25 e sai che mentalmente il tuo sforzo durerà non più di due ore circa. In quel periodo no. Ad esempio il match point contro Cuba ai Mondiali del 1990 è uno stillicidio: Despaigne che 9 volte ci annulla il punto decisivo. Televisivamente parlando è chiaro che è più comodo seguire questa pallavolo, ma quella era drammatica, era una tragedia greca e finivi arrancando. Questo era molto più logorante a livello mentale. Pensare che a tutto ciò si aggiunge l’ossessione di vincere ad Atlanta, rende tutto ancora più faticoso. Io ho cercato di trasmettere lo stress e la fatica mentale che c’era dietro le partite e gli allenamenti. Gli ultimi due capitoli del libro, all’interno dei quali è descritto il cammino verso Atlanta, ho provato a rendere questa ossessione; un continuo ripetere la stessa cosa che altro non era che il pensiero fisso di quei giocatori in quegli anni: «vincere l’Olimpiade ad Atlanta». Questo mi sembra un fattore che ha reso ancora più grande quella squadra: è stata grande nonostante si portasse appresso questo peso mediatico di dover vincere l’Olimpiade a tutti i costi. Ciò ha trasformato il viaggio verso Atlanta in un viaggio bellissimo dove la tavola è stata apparecchiata da vittorie in Mondiali e Europei che solo oggi forse acquistano il loro reale valore. Sono stati grandissimi perché non sono stati ossessionati dall’energia negativa di dover vincere a tutti i costi».
Per leggere la recensione de La squadra che sogna, clicca qui
Titolo: La squadra che sogna
Autore: Giuseppe Pastore
Editore: 66thand2nd
Anno: 2020
Pagine: 199