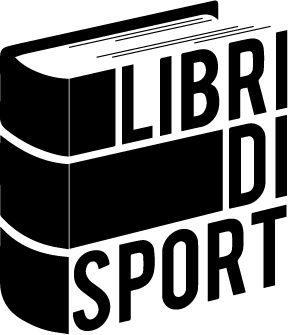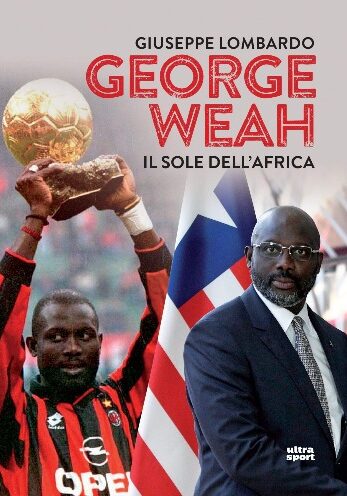Intervista a Flavio Tranquillo (parte 2)

Seconda parte della chiacchierata con l’autore di Time Out
INTERVISTA DI ALBERTO COGHI E CARLO NECCHI
PER LEGGERE LA PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA A FLAVIO TRANQUILLO CLICCA QUI.
Da addetto ai lavori e da appassionato, che ruolo dai alla cosiddetta letteratura sportiva, considerando anche i tre libri che hai scritto? Accanto ai sempre più influenti social network, può essere un canale interessante?
«Non so se i canali di trasmissione facciano il contenuto. Credo che il contenuto dovrebbe essere sempre in primo piano e bisognerebbe parlare di quello; se poi viene veicolato in un modo o in un altro è abbastanza irrilevante. Se parliamo del contenuto penso che la differenza elementare sia tra: porsi di fronte a una vicenda con l’intento di fare audience, o di lasciar contente le persone che mi sentono, oppure senza nessuna di queste due prospettive. Credo che quest’ultima cosa sia giornalismo mentre le prime due, pur legittime, non lo siano. Giornalismo dovrebbe essere una cosa per cui io, utente, pago, per avere un servizio il più possibile scevro da questi condizionamenti. Temo che oggi stia più avvenendo il contrario».
Cioè?
«Credo che il giornalismo si stia interrogando molto, spinto anche da pressioni esterne, su come vendere di più e su come lasciare più contente le persone, ovvero su come raccontargli quello che già pensano. Non è un esercizio negativo di per sè, ma nel momento in cui scompare la terza cosa di cui parlavo, cioè il ragionare senza questa prospettiva ultima, emerge un problema di ricchezza, non in termini materiali ma intangibili. Una depressione di ricchezza del sistema comunità».
Oggi dunque, nel momento in cui tu fai una telecronaca, qual è il tuo obiettivo numero 1?
«Di sicuro c’è stata un’evoluzione totale, non so se in meglio o in peggio. La telecronaca non è un esercizio di carattere puramente giornalistico, o meglio: il tempo di mediazione inesistente non permette di elaborare l’avvenimento e questo, rispetto alle mie propensioni personali, lo trovo anche limitante. L’unico obiettivo è quello di dire: in questo momento, dagli elementi che percepisco, mi sembra che stia succedendo questo. Non sto a chiedermi se a qualcuno può piacere di sentirsi dire una cosa o un’altra. Per esempio, per anni mi sono sentito dire cose tipo: “vogliamo sentire i nomi dei giocatori, perché racconti storie extra campo?”, mentre oggi mi dicono “sentire solo Thompson passa a Durant che fa canestro non ci interessa”. Personalmente credo che il mestiere del telecronista, che ha dei limiti ma non è necessariamente così banale come dire “tizio passa a caio”, sia quello; quando invece scrivo un libro cerco di fare tutto ciò che in telecronaca non posso, per esempio spiegare che il mestiere del giornalista è quello di farsi domande ed elaborarle andando sempre a quella successiva».
Il nome di Aldo Giordani compare spesso vicino al tuo. Che tipo di rapporto hai avuto con lui? C’è qualcosa che ti ha lasciato per la tua formazione giornalistica?
«Per il significato che do al termine giornalista oggi ovviamente sì, ma non direi -col massimo rispetto- che Giordani è colui che mi avrebbe aiutato. Lui era telecronista della RAI, con la quale io non avevo niente a che fare, e direttore della rivista SuperBasket. Io un giorno, per circostanze casuali, ho scritto un pezzo e l’ho mandato alla rivista; Giordani aveva l’abitudine, bella o brutta che fosse, di prendere delle cose che gli arrivavano e metterle in pagina anche se non erano scritte da professionisti o non le aveva chieste lui; è una grande cosa per certi versi, e un grande rischio per altri. Il mio rapporto diretto con lui era limitato a questo e al fatto che, mentre io facevo i primi passi nella professione, lui stava terminando una maratona olimpica e ci siamo incrociati per un microsecondo. Non sto parlando di uno che lavorava con me e mi vedeva in ufficio. Detto questo, ha avuto una grande influenza».
Quale?
«A me sarebbe piaciuto che altre persone, più avanti, mi avessero dato una formazione giornalistica un po’ più consistente di quella che non ho avuto. Forse non avrei dovuto cercarmela per i fatti miei, lentamente e con tutte le conseguenze del caso. L’impatto di Giordani, come quello di Federico Buffa e Dan Peterson, è stato quello di avere una modalità di linguaggio che piace molto, innovativa e moderna nel senso più pieno del termine. Si può essere moderni anche utilizzando termini che sarebbero comici, da quanto desueti sono, ma che ugualmente all’epoca non stonavano ed erano moderni, come quelli che usava Giordani. Da lui ho mutuato la possibilità di provare a utilizzare uno stile espressivo, colorito per esprimere un concetto, che secondo me è una cosa di grande valore. Il problema di fondo rimane un altro».
Ovvero?
«Qual è il concetto e qual è il contenuto. Ognuno risponde per sé a questa domanda; oggi ritengo che il contenuto sia un po’ sacrificato rispetto allo stile. Se sei un grandissimo come i tre che ho citato te lo potresti anche permettere, se invece non lo sei forse varrebbe la pena di preoccuparsi di più del contenuto. Attenzione: contenuto e forma non sono nemici ma i due più grandi alleati, la forma è contenuto in questo lavoro, è importante quanto il contenuto. Il problema è risolvere o evadere il problema del contenuto concentrandosi solo sulla forma: è un rischio che oggi è molto presente, ieri non lo era perché nel mio settore i Giordani, Peterson e Buffa che ho citato erano talmente avanti da rappresentare una forma di progresso e di ispirazione elevatissima, da cui io ho preso a piene mani e di cui li ringrazio. Oggi mi sembra ci sia il rischio di fermarsi lì e di non risolvere altre questioni importanti».
Una domanda sul tuo rapporto con Davide Pessina, e sulla transizione dal lavoro con Federico Buffa al lavoro con lui. Che cambiamento è stato? Ha comportato difficoltà?
«Premetto che una delle poche cose di cui sono contento in retrospettiva è aver completamente perso la mistica della telecronaca. Cioè il pensiero che la telecronaca sia un esercizio di grande interesse per l’umanità, o per meglio dire che sia al centro della vicenda. Sono abbastanza certo, ma mi autoassolvo perché penso sia umano, che all’inizio della mia carriera credessi che si giocassero le partite perché io potessi fare la telecronaca. Questa è una conseguenza abbastanza comune dell’intensità, dell’attaccamento con cui uno comincia e continua a fare questo lavoro. Ad un certo punto però la ragione dovrebbe dirti che non è così: si giocano le partite e a lato tu cerchi di raccontare la maggior quantità di cose che succedono nel modo migliore possibile».
In questo cosa può fare la differenza?
«Quello che fa la differenza è se questo processo è evolutivo o involutivo, ovvero se tendi a fare meglio una telecronaca cercando pian piano di vedere qual è per te il meglio. È un miglioramento molto soggettivo, di cui puoi darti atto solo tu, perché il fatto che aumenti o diminuisca l’audience o i like su Facebook non è di per sé un miglioramento o un peggioramento. Se fossi arrivato a 60 anni e non sapessi che cosa servisse per farmi dare più like e più audience sarei un minus habens, il problema è se vale la pena sacrificare questo per ciò che io ritengo un valore più alto, cioè quello di provare a fare il proprio lavoro nella miglior maniera possibile. Io vado testardamente per la mia strada, che non è di migliorare ma di provare a migliorare».
Nello specifico cosa significa provare a migliorare?
«Ad esempio significa aver asciugato moltissimo le considerazioni extra, che pure mi interessano come dimostra il libro che ho scritto: ma durante la telecronaca sto facendo la telecronaca. Poi, per quanto riguarda il compagno: nel 2013 mi sedevo con Buffa, dall’anno dopo con Pessina; se un giorno Davide volesse ritirarsi mi siederò e lavorerò con chi verrà al suo posto. Non vivo nella mistica di “non c’è più Buffa, quindi devo fare io un pezzo di Buffa”, o cose simili. Stiamo parlando di professionisti, tutti quelli con cui ho lavorato in questi trent’anni hanno condiviso l’idea di fondo che sia una bella cosa fare questo lavoro. Una volta che c’è questo… Io faccio già fatica a provare a farlo al meglio io, non mi metto a pensare se venga meglio con questo o quel compagno; io devo lavorare sempre nella stessa maniera, il mio compagno dovrà fare il suo in un certo modo. Per questo se mi chiedete com’è stato passare da Buffa a Pessina posso dire che quasi non me ne sono accorto, riconoscendo naturalmente che hanno uno stile, un vissuto, delle idee diverse. Ma non è meglio uno o peggio l’altro».
Titolo: Time Out. Ascesa e caduta della Mens Sana o dello sport professionistico in Italia
Autore: Flavio Tranquillo
Editore: Add editore
Anno: 2019
Pagine: 300
Per leggere la recensione a Time Out di Flavio Tranquillo clicca qui.