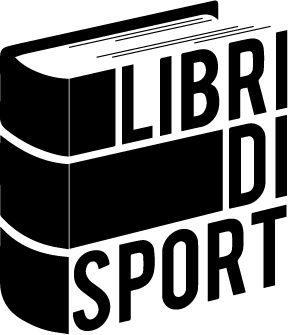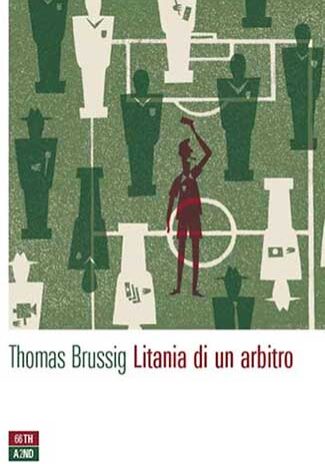Intervista a Sandro Bonvissuto
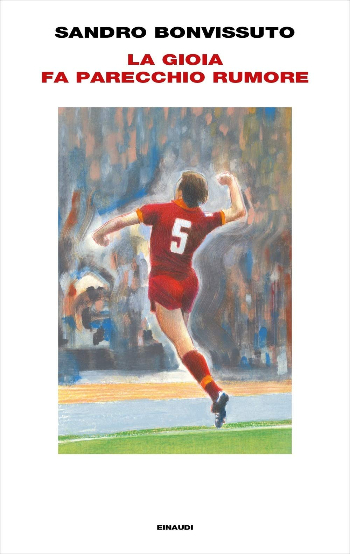
Chiacchierata con l’autore de La gioia fa parecchio rumore
Sandro Bonvissuto è nato l’1 giugno 1970, ovviamente a Roma, dove vive, legge, scrive e lavora (in rigoroso ordine d’importanza). Laureato in Filosofia alla Sapienza, da anni lavora nella trattoria “La Sagra del Vino”, dove lo si può trovare ogni sera. Gli piace che gli venga dato del “tu”, non del “lei”. A febbraio 2020 è uscito, per Einaudi La gioia fa parecchio rumore, arrivata ben otto anni dopo il suo grande debutto narrativo, Dentro (2012, Einaudi), con cui vinse il Premio Chiara e arrivò tra i finalisti del Premio Dessì. Sempre con Einaudi, nel 2013 è stato co-autore dell’antologia Scena padre. La gioia fa parecchio rumore è però il suo primo romanzo, nel quale parla di Roma, della Roma e di quella cosa di cui «credi di sapere tutto ma ‘nvece nun sai un cazzo»: l’amore.
Definiresti La gioia fa parecchio rumore un libro di sport?
«Avoja! La narrativa sportiva è di un’epicità mostruosa. Io sono cresciuto con quella roba lì, leggendo Soriano, Galeano, le loro storie di partite sui campetti de terra, ‘e righe de calce. Il pallone è quello, è roba della gente. Quindi sono onoratissimo di aver scritto un libro di calcio, di sport. Che poi, di calcio se sono occupati pure Leopardi, Pasolini, Saba. De che stamo ‘a parlà?».
Be’, in Italia spesso ci si limita a considerare letteratura sportiva solo le biografie degli atleti, l’aneddotica più che la narrazione…
«Questa è la presunzione di una società borghese, ignorante, che non riesce a recuperare nel gesto tecnico, nell’amore di un bambino e nell’esagerazione del racconto di un bambino, qualcosa di grande. Ma noi, io e quelli di cui parlo nel libro, siamo cresciuti così. E semo cresciuti bene».
Il calcio, quindi, non è solo un gioco?
«Ma che scherzi? La gente che crede che il calcio sia un mondo de deficienti sottosviluppati è in malafede. Il calcio ha ereditato la teatralità dell’agone, della contesa, della corrida, della corse con le bighe ar Circo Massimo. Panem et circenses. Il calco è il surrogato reale del teatro, è roba forte per davvero».
E per questo, dunque, è letteratura?
«Ma certo. Lo è per il modo in cui attinge a un mondo romantico e di valori nel quale si torna a casa piangendo perché la Roma ha perso una partita. La letteratura sportiva pesca da quella roba lì, mica dai mondi e dai modelli borghesi di tanti, troppi. Se vinci sei contento, se perdi stai male. E stai male tanto, te cambia tutto, mandi a fare in culo tu’ madre e la tu’ ragazza. Che te frega, la Roma ha perso e stai male, punto. È stupido? No, è umano».
Perché hai scelto di raccontare questo, nel tuo primo romanzo?
«E che dovevo raccontà? Ho voluto raccontare un modo fatto di gente a cui gliene frega, gente che ama, che è pronta a lottare per qualcosa e a vivere per quel qualcosa. Che poi è il mondo in cui sono cresciuto. Oggi, invece, alla gente non gliene frega un cazzo. Ma non del calcio eh, di tutto. In quello che ho raccontato ci sono dei valori. Ridicoli magari, ma ci sono. Gli altri invece che valori propongono? Ne hanno da proporre? No. Ed è per questo che la letteratura sportiva, quella calcistica in particolare, ha un bagaglio epico fortissimo: perché lì ci sono dei valori. Se poi qualcuno mi dice che sono valori futili, allora io je dico de farsi li cazzi sua».
Nel libro si racconta come vengono plasmati questi valori. E perché ciò avvenga, è fondamentale per il protagonista essere parte di qualcosa, immerso in un mondo che è imbevuto di quei valori. Lo si capisce ben quando racconti l’arrivo a Roma di Falcao.
«Non è un libro autobiografico, ma c’è anche tanto della mia vita. E io andai davvero ad accogliere Falcao all’aeroporto. Come il protagonista del libro, ero piccolo: pensavo non di essere er primo, ma de essere proprio l’unico. M’ero preparato pure tutto il discorso. E invece, alle 9.35 del 10 agosto, c’erano ottomila persone. Ottomila. Ed è lì che ho capito di amarli tutti quelli lì. Volevo essere come loro. Lo dissi a mio papà e lui mi rispose che non dovevo preoccuparmi, che non dovevo manco studià pe’ essere come loro: lo eravamo già».
È una visione in controtendenza, per certi versi. Spesso si tende a elogiare l’individuo nella sua unicità, tu lo fai invece inserendolo in una comunità. Senza questa, non esiste il singolo.
«L’individualismo è una sovrastruttura borghese der cazzo. Siamo tutti uomini, i sentimenti sono gli stessi per tutti. “Io so’ fatto a modo mio” è una gran cazzata: nella mia famiglia eravamo tutti uguali. Le madri dei miei amici erano mia madre».
Per questo nessun personaggio del libro, a parte uno, viene identificato con un nome proprio?
«Esatto, per questo sfrangiamento dell’uguale. Il nome ti consegna un individualismo che io respingo anche dal punto di vista letterario. Poi ok, se sei Van Gogh e n’artro discorso. Ma la verità è che nessuno, a parte Van Gogh, è Van Gogh, quindi…. Questo è un libro popolare, antropologico, che parla di un’altra Roma, di un altro mondo».
Racconti anche Roma senza raccontarla. Ma si capisce anche che era un’altra cosa rispetto alla Roma di oggi.
«Era un posto dove si stava bene, a casa tua quanto a casa degli altri. Oggi è cambiata tanto, come tutta l’Italia. Allora c’era un’ondata di benessere che permise a tutti noi di stare davvero bene. E lo siamo stati, prima di distruggere un Paese, il nostro, che era la prima potenza d’Europa. La Germania era divisa in due, la Francia era straziata da problemi razziali che manco loro sanno… Eravamo noi, belli e forti. Qui se campava bene: luce, mare, sole, belle fregne».
Riepilogando: La gioia fa parecchio rumore è un libro sul calcio, sulla città di Roma, sulla Roma, sulla vita. Giusto?
«È un libro sul calcio? Anche no. È un libro su Roma? Anche no. È un libro su tutto e niente. È un libro d’amore, che racconta la storia d’amore di un regazzino per la Roma. E quell’amore resta anche quando arriva la fregna, te lo assicuro. Cambia solo come lo esprimi. È un’autopsia di quello che si prova. E attorno a lui racconto una società che era come lui».
Per te la Roma (squadra) è rimasta la stessa cosa che era per il protagonista del romanzo?
«Tutto cambia, tutti cambiamo. Dell’amore credi di sapere tutto ma ‘nvece nun sai un cazzo. L’amore è un clamoroso equivoco della vita. Una menzogna che ti racconti da solo. Di quello cos’è rimasto? Guardo la partita, vado allo stadio. Ma a me del calcio non me ne frega un cazzo, me ne frega solo della Roma. Quel sentimento lì fu l’incontro con l’amore. È chiaro, poi, che se avessi raccontato la storia di un diciassettenne avrei raccontato altro. Ma quell’amore, il primo, resta per sempre».
È proprio perché parli di amore che hai deciso di chiudere il libro prima del fischio d’inizio della finale di Coppa dei Campioni del 1984 persa ai rigori contro il Liverpool?
«Quello è l’inizio della mia psicanalisi. Non so se te rendi conto: la Roma perde la finale di Coppa dei Campioni in casa. L’unica volta che ci arriviamo, perdiamo. Potevamo cambiare la storia nostra e d’Europa e perdiamo ai rigori. Sono tornato a casa a piedi distrutto. È come portare una croce, una roba del genere. Io sono nato l’1 giugno e mia madre due giorni dopo quella finale me fece una torta. Glielo dissi proprio: ma stai a scherzà? È una mancanza de rispetto questa. E lei mi chiese scusa, capì. Io non ho mai compiuto 14 anni. Chi era lì, all’Olimpico quel giorno, è rimasto offeso per sempre. Chi c’era c’ha un’invalidità, ce dovrebbero dà la 104. Detta così pare una cosa ridicola, ma è l’attribuzione che tu dai a un evento a dargli un peso. Chi era là, così come i personaggi del libro, non sanno che ci sono cose più importanti. Lì erano, eravamo, tutti uguali».
E qual è la morale?
«La morale è che se tu c’hai un impianto di valori, anche stupidi o addirittura sbagliati, hai comunque uno sviluppo emotivo sano. Il problema è quando non ci sono proprio i valori, perché allora cresci con una sorta di amputazione dell’affettività. La gioia fa parecchio rumore, alla fine, parla di questo: di amore e di valori. Di noi, di cosa eravamo, della Grande Famiglia italiana, coi suoi casini ma soprattutto con i suoi valori e il suo amore. In Norvegia so’ più organizzati, precisi, meno casinisti? E vacci tu, a me non me piace. Me piace come eravamo e come siamo. E l’ho raccontato».
Chiudo con la domanda che facciamo a tutti voi scrittori, sebbene tu abbia già risposto in parte: qual è il libro sportivo che consiglieresti a tutti?
«Direi tutto ciò che hanno scritto Galeano e Soriano. Ma se devo dirne uno, allora Fútbol. Storie di calcio di Soriano. Lui univa un substrato parasportivo a una grande umanità. Era pazzesco. Apprezzo anche Nick Hornby, che ha fatto un grande lavoro nel raccontare il calcio, ma la realtà a cui lui fa riferimento è molto, troppo distante dalla nostra. Cioè, noi Margaret Tatcher non ce l’avevamo al Governo, ma proprio in casa. Anzi, io ne avevo due: mi’ madre e mi’ nonna. Quindi è ovvio che mi senta distante da Hornby, no?».
Per leggere la recensione de La gioia fa parecchio rumore clicca qui.
Titolo: La gioia fa parecchio rumore
Autore: Sandro Bonvissuto
Editore: Einaudi
Anno: 2020
Pagine: 200