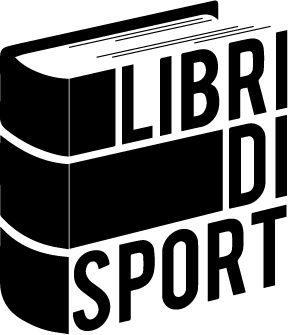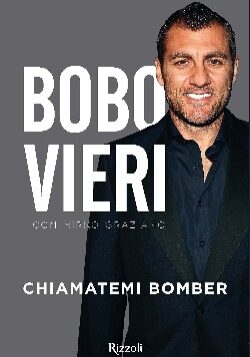Intervista a Enzo D’Orsi

Chiacchierata con l’autore de Gli undici giorni del Trap
Enzo d’Orsi, classe 1953, è una delle storiche firme del giornalismo sportivo italiano. La sua carriera è strettamente legata alla storia della Juventus, visto che dal 1979 al 2000 ha seguito la Vecchia Signora per il Corriere dello Sport. Ha raccontato oltre 250 sfide europee, migliaia di partite di campionato, oltre che quattro Mondiali e cinque Europei di calcio. Ha scritto anche per Paese Sera e Leggo. Il suo secondo romanzo, uscito da poco e pubblicato da Edizioni inContropiede, si intitola Non era champagne – La Juve di Maifredi, Baggio e Montezemolo; il primo, pubblicato dalla stessa casa editrice ed edito nel 2018, si intitola invece Gli undici giorni del Trap ed è dedicato alla finale di Coppa dei Campioni persa dalla Juventus ad Atene contro l’Amburgo. Ed è proprio su questo libro che verte la nostra intervista.
La finale del 1983 non fu la prima a essere stata persa dalla Juventus. Perché però da molti, forse lei compreso, viene ritenuta l’inizio della “maledizione” (o della ossessione) juventina con le finali continentali?
«Atene fu la seconda finale. La prima, a Belgrado nel 1973 contro il formidabile Ajax di Cruyff, era passata in cavalleria: la Juve perse 1-0 senza aver mai creduto di poter vincere. A distanza di quasi mezzo secolo, si può dire che una Juve meno rassegnata avrebbe anche potuto ribaltare le previsioni. Ad Atene, invece, c’era la convinzione – nella maggior parte dei tifosi, la certezza – che la coppa sarebbe finalmente arrivata, ma un po’ tutti – certo, non Trapattoni – sottovalutarono la forza dell’Amburgo, che non aveva i sei campioni del mondo, non aveva Platini e Boniek (e neppure Bettega), ma era un collettivo organizzatissimo, in grande condizione atletica, ed aveva anche quattro giocatori al di sopra della media tedesca, ovvero Kaltz (il migliore in campo, quella sera), Magath, Hrubesh e Milewski. Perduta quella finale, e vinta la successiva all’Heysel nelle circostanze che tutti conoscono, nasce l’ossessione: il popolo bianconero si sente vittima di una sorta di maledizione, che non esiste nella realtà. Esistono partite che nascono male e finiscono peggio. Ed esistono partite, contro avversarie più forti come il Barcellona nel 2015 e il Real Madrid nel 2017, che nelle finali paradossalmente esprimono il meglio di sè».
Perché ha scelto di far parlare Trapattoni in prima persona? Pura scelta stilistica?
«Una scelta stilistica, certo. Ispirata dal Brian Clough de Il maledetto United, forse il più bel libro che io abbia mai letto sul calcio, forse superiore anche a Febbre a 90 di Nick Hornby. Non voglio assolutamente fare paragoni con David Peace, uno scrittore eccellente, ma l’idea è stata quella di affidare all’allenatore il racconto – romanzato, ma basato su fatto indiscutibili – della preparazione di quella finale. Preparazione che, vista a posteriori, non fu perfetta, e non solo per qualche responsabilità di Trapattoni».
È molto interessante la riflessione tattica che attraversa tutto il libro. Visto che da narratore ha già vestito i panni del Trap, lo faccia anche da allenatore: come avrebbe preparato quella partita?
«In quel periodo storico, la tattica era considerata fondamentale, così come la conoscenza degli avversari. Era un altro calcio. Trapattoni voleva sapere tutto, io parlavo tutti i giorni con lui, lo interrogavo, coglievo le sue preoccupazioni, soprattutto il suo stupore di fronte al clima di festa anticipata che c’era a Torino e non solo. Come se Atene fosse una formalità. Lui sapeva che l’Amburgo sarebbe stato una brutta bestia, ma giornali e tv non lo aiutarono, basta rivedere qualche filmato dell’epoca per rendersi conto della situazione».
«Tutti i cronisti – di calcio, di economia, di politica, di giudiziaria – hanno sempre un’idea di come avrebbero fatto loro. Probabilmente mi sarei comportato come Trapattoni, per due ragioni. La prima: in coppa, quella squadra aveva fatto benissimo, era arrivata imbattuta alla finale. La seconda: Rossi, ma anche altri, non era non in grande forma, ma chi avrebbe escluso dalla finale il capocannoniere del Mondiale vinto dagli azzurri soltanto dieci mesi prima? Nessuno! Anche perchè, a differenza di quel che accade oggi, la riserva di Rossi era il giovanissimo Galderisi, bomber promettente ma acerbo. Se Trap avesse avuto in panchina un Higuain, un Mandzukic o anche un Quagliarella, magari avrebbe rischiato. Certo, avrebbe potuto proteggersi meglio sulla fasce, utilizzando Marocchino, ma Trap immaginava una Juve in grado di imporre il gioco per lunghi tratti della partita, una Juve che avrebbe dovuto costringere i tedeschi a correre ai ripari. Cosa che non avvenne».
Non pensa che la Juve di oggi abbia delle analogie con quella di allora? Non c’è il rischio che la pressione, l’obbligo di vincere, faccia implodere il tutto?
«Le analogie, a trentacinque anni di distanza, sono vaghe. E’ cambiato tutto. La coppa resta l’obiettivo più importante, dunque le tensioni non mancano, ma c’è anche il gusto della sfida. L’acquisto di Cristiano Ronaldo dimostra che il traguardo è quello, mai come adesso. Arrivare in finale è sempre un grande onore, non è vero che vincere sia la sola cosa che conta. Conta essere sempre molto competitivi, e da questo punto di vista alla Juve c’è ben poco da rimproverare».
Come si “prepara” un libro del genere? Lei seguiva quotidianamente quella squadra, si è affidato solo ai suoi ricordi o anche alle testimonianze di colleghi e calciatori? Trapattoni lo ha letto? Si è ritrovato nei pensieri del “suo” Trapattoni?
«Il libro è stato scritto qualche anno fa, anche se è uscito nel settembre del 2018. I ricordi mi hanno aiutato molto, così come alcuni dettagli ricostruiti attraverso testimonianze di colleghi, ritagli di giornali, chiacchierate con alcuni protagonisti di quella finale, a cominciare da Marco Tardelli. Per me, Atene era la prima finale. Non nascondo che ero emozionato nel seguire l’avvicinamento della squadra alla partita più importante della stagione. Quanto a Trapattoni, avevo con lui un dialogo continuo, lo controllavo a uomo, ero e sono solidale con lui, so che la casa editrice gli ha spedito il libro, non so se lo abbia già letto. Posso dire che Trapattoni non avrebbe meritato di perderla, quella finale. Di perderla in quel modo, con una squadra svuotata che andò incontro al proprio destino senza ribellarsi. Mi impressionò un dato, quella sera del 25 maggio 1983: la Juve, che aveva tiratori grandissimi come Platini e Cabrini, ma anche Tardelli e Boniek, non seppe conquistare neppure un calcio di punizione a 20, massimo 25 metri, dalla porta tedesca in novanta minuti!».
Per leggere la recensione de Gli undici giorni del Trap, clicca qui
Titolo: Gli undici giorni del Trap
Autore: Enzo D’Orsi
Editore: Edizioni InContropiede
Anno: 2018
Pagine: 132
Per leggere la recensione di Non era champagne. La Juve di Maifredi, Montezemolo e Baggio di Enzo D’Orsi, clicca qui.
Per leggere la recensione di Michel et Zibi di Enzo D’orsi, clicca qui.